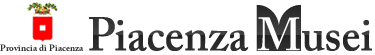home > Chiese > Cattedrale di Piacenza > Visita alla Chiesa
La cattedrale fu edificata a partire dal 1122 sulle rovine della precedente chiesa di Santa Giustina, distrutta da un sisma nel 1117.
La facciata a due salienti con loggette cieche è suddivisa in tre parti da due semicolonne che ingentiliscono e slanciano la struttura e che incorniciano il grande rosone. La parte inferiore è in marmo rosa veronese, al tempo molto preziosa, rispetto all’arenaria locale. I portali di ingresso del Duomo, dotati di eleganti protiri, sono decorati con sculture riconducibili alla scuola di Wiligelmo, a sinistra, di Niccolò a destra; i leoni del protiro centrale sono del 1527 e sostituiscono quelli trecenteschi, di cui uno al Museo Civico. Di grande importanza storico-artistica sono le storie di Maria e di Gesù nelle architravi dei portali. Una galleria di archetti pensili percorre la facciata e le navate laterali, mentre quella centrale è illuminata da grandi monofore a sesto acuto.
Il campanile fu costruito un secolo più tardi e nel 1341 il "magister lignaminis et petre" Pietro Vago innalzò la guglia sulla quale fu collocato un angelo bronzeo, considerato il simbolo della città e definito affettuosamente in parlata piacentina "Angil dal Dom".
Sotto la cella campanaria verso la piazza fu installata nel 1495, per volere di Ludovico il Moro, una gabbia (tuttora visibile) per rinchiudervi condannati per reati contro la Chiesa e lo Stato; non vi sono però documenti che attestano il suo utilizzo. Nell’abside, che si affaccia su via Vescovado, si apre una splendida finestra decorata con sculture duecentesche raffiguranti, nella sezione superiore l’Annunciazione e nella sezione inferiore due profeti.
L’interno maestoso, a croce latina, è diviso in tre navate su poderosi pilastri, con sovrastanti loggette dei matronei di eredità paleocristiana. Sul primo pilastro a destra è raffigurata ad affresco la "Madonna delle Grazie" del sec. XV considerata dai piacentini come immagine miracolosa. Sugli altri pilastri sono scolpite le formelle delle corporazioni piacentine del XII secolo, dette paratici, che finanziarono la costruzione della cattedrale e che rappresentano i mestieri più importanti: carradori, calzolai, ciabattini, tessitori, fornai, tintori e altri. Molto interessanti i capitelli perimetrali con le storie di David.
Nel punto di intersezione tra la navata centrale ed il transetto si inserisce il poderoso tiburio ottagonale affrescato con figure di Profeti da Pier Francesco Mazzuchelli detto il Morazzone (1626) e, dopo la sua morte, con le figure delle Sibille da Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino (1627), grazie al patrocinio del cardinale Odoardo Farnese. Nella parte sinistra del transetto è conservata la vasca battesimale del precedente edificio paleocristiano, insieme a un dipinto raffigurante San Girolamo, opera del pittore bolognese Guido Reni, è un piccolo interessante polittico dipinto con scene bibliche da Serafino dei Serafini. Sulle parete del transetto a sinistra è affrescato un San Cristoforo ascrivibile al XIII secolo.
Dietro l’altare maggiore è situato un importante polittico di legno policromo opera di dell’intagliatore Antonio Burlengo e del doratore Bartolomeo da Groppallo (1447); il coro fu realizzato nel 1471 da Giovanni e Giacomo Genovesi. Sempre nel presbiterio si segnalano gli affreschi dell’Incoronazione della Vergine e l’Assunzione realizzati tra il 1605 e il 1609 da Camillo Procaccini - a cui si deve anche la pala d'altare raffigurante il Transito di Maria Vergine (oggi collocata sulla controfacciata) - e da Ludovico Carracci, i bellissimi angeli nel cielo azzurro del santuario. Di Lodovico anche un possente S. Martinonella controfacciata sopra il portale sinistro.
La cripta, che conserva le reliquie di Santa Giustina, prima patrona di Piacenza, presenta 108 colonne con capitelli variegati, molte delle quali sono frutto di restauro ottocentesco di gusto neogotico curato dall’arch. Camillo Guidotti, che riportò il paramento murario alla nudità medioevale; una parte degli affreschi seicenteschi del bolognese Marc’Antonio Franceschini sono conservati presso il palazzo vescovile. Vi si conservano anche diffuse tracce di affreschi, ascrivibili al XV secolo.